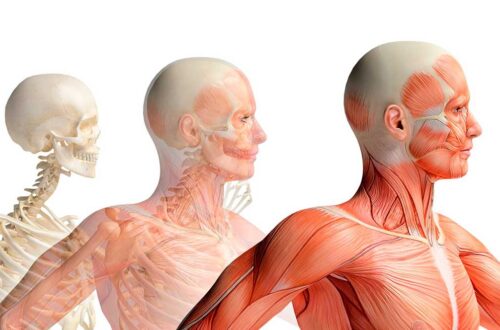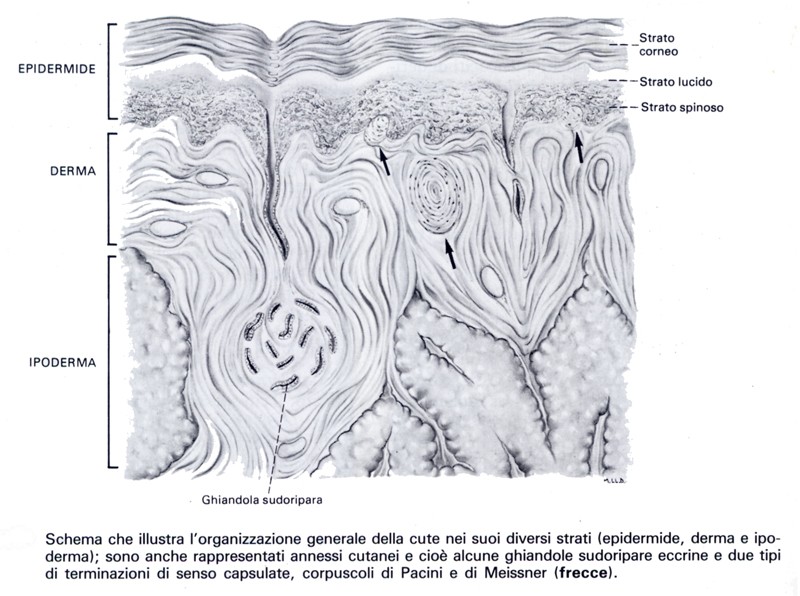Struttura del cristallino
Il cristallino è costituito da una capsula (o cristalloide) dalla quale è interamente avvolto; al di sotto di questa, nella faccia anteriore, si trova l’epitelio del cristallino al quale segue infine la sostanza del cristallino. La capsula del cristallino (o cristalloide) è una membrana continua, di aspetto omogeneo, che al microscopio elettronico presenta una struttura lamellare. Tra i suoi costituenti si dimostra un collagene che non si organizza in formazioni a struttura periodica, sul tipo delle fibrille, bensì in formazioni laminari.
Fascia dorsale superficiale
La fascia dorsale superficiale è sottile e si unisce in alto al legamento dorsale del carpo, per perdersi inferiormente sulle dita; superficialmente è in rapporto con il sottocutaneo, profondamente con i tendini estensori. Articolo creato il 18 marzo 2010. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Sostanza P
La sostanza P è contenuta in cellule enterocromaffini contraddistinte come sottopopolazione EC1. È un polipeptide di 11 aminoacidi che si localizza in granuli che contengono anche 5-idrossitriptamina e sono fortemente argirofili. Lo stesso polipeptide è anche localizzato nelle terminazioni nervose del plesso mienterico. Si ritiene che la sostanza P svolga un ruolo regolatore della peristalsi intestinale. Le cellule EC1 sono principalmente localizzate nella mucosa dell’intestino tenue e crasso. Le cellule enterocromaffini della mucosa gastrica non contengono motilina né sostanza P; esse vengono denominate cellule ECn e, accanto alla 5-idrossitriptamina, contengono probabilmente ormoni polipeptidici non ancora identificati. Articolo creato il 15 agosto 2011. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Quiz di nefrologia
In questa pagina è possibile esercitarsi su quiz di nefrologia. Puoi scegliere un test da 10, 25, 50, 100 o 140 domande, estratte da un archivio di centinaia di domande (della stessa disciplina). Ogni volta che si ripete un quiz le domande saranno diverse e l’ordine delle risposte mescolato. Ogni domanda presenta 5 possibili risposte di cui 1 sola corretta. Le risposte corrette/errate saranno visualizzate subito dopo aver risposto, nonché al termine del quiz. Per esercitarti su altre discipline o simulazioni, vai qui. Hai riscontrato errori? Invia un messaggio per comunicarlo! Attenzione! Tutti i quiz possono essere svolti liberamente, senza registrazione al sito. Se si desidera archiviare le prove effettuate nella propria…
Prova ufficiale Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo – Area clinica
L’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo consisteva in due prove da tenersi nella stessa giornata. Tale esame è stato abolito a partire dalla seconda sessione 2019. Le due prove si basavano su quiz a risposta multipla, una per l’area preclinica, l’altra per l’area clinica, estratte dal database ufficiale reso noto dal MIUR. In questa pagina è possibile simulare una prova ufficiale dell’Esame di Stato con quiz sull’area clinica secondo le regole ufficiali dell’esame, ovvero: 90 domande a risposta multipla, ognuna con 5 possibili risposte; 1 sola risposta corretta; 1 punto per risposta corretta; 0 punti per risposta non data; -0,25 punti per risposta errata; 150 minuti…
Fossa pterigopalatina
La fossa pterigopalatina è un angusto spazio osseo situato sotto l’apice della cavità orbitaria. È limitata medialmente dalla parte perpendicolare dell’osso palatino, in avanti dalla tuberosità mascellare, in dietro dalla faccia sfeno-mascellare del processo pterigoideo.
Quiz di chirurgia maxillo-facciale
In questa pagina è possibile esercitarsi su quiz di chirurgia maxillo-facciale. Puoi scegliere un test da 10, 25, 50, 100 o 140 domande, estratte da un archivio di centinaia di domande (della stessa disciplina). Ogni volta che si ripete un quiz le domande saranno diverse e l’ordine delle risposte mescolato. Ogni domanda presenta 5 possibili risposte di cui 1 sola corretta. Le risposte corrette/errate saranno visualizzate subito dopo aver risposto, nonché al termine del quiz. Per esercitarti su altre discipline o simulazioni, vai qui. Hai riscontrato errori? Invia un messaggio per comunicarlo! Attenzione! Tutti i quiz possono essere svolti liberamente, senza registrazione al sito. Se si desidera archiviare le prove effettuate nella…
Poligono di Willis
La vascolarizzazione dell’encefalo è fornita dalle arterie vertebrali, basilare,carotidi interne con i loro rispettivi rami collaterali e terminali unite, in via funzionale, dal poligono di Willis (o circolo arterioso o eptagono di Willis). Esso è un importante anello anastomotico situato nella cisterna interpeduncolare, in rapporto con la faccia inferiore dell’encefalo, che circonda il chiasma ottico e le formazioni della fossa interpeduncolare. È formato: In avanti, dal tratto iniziale delle due arterie cerebrali anteriori, unite fra loro dall’arteria comunicante anteriore. Sui lati, dalle arterie comunicanti posteriori che, originate dall’arteria carotide interna, raggiungono l’arteria cerebrale posteriore dello stesso lato. In dietro, dal tratto iniziale delle arterie cerebrali posteriori, derivanti dalla biforcazione del…
Linfonodi dell’arto inferiore
I linfonodi dell’arto inferiore sono in prevalenza raccolti nel linfocentro inguinale. Altri, in un numero assai inferiore, sono situati nel cavo popliteo. Altri ancora, per lo più isolati, sono intercalati sul decorso dei vasi profondi della gamba. Un linfonodo tibiale anteriore, un linfonodo tibiale posteriore, piccoli linfonodi peronieri possono essere situati sul decorso degli esili collettori linfatici satelliti dei vasi omonimi. I collettori efferenti si portano ai linfonodi poplitei.
Stomaco
Lo stomaco è un organo impari che si presenta come un tratto dilatato del canale alimentare, interposto tra esofago e intestino tenue. È situato nella cavità addominale subito al di sotto del diaframma e occupa l’ipocondrio sinistro e una parte dell’epigastrio. In esso gli alimenti si accumulano e sostano temporaneamente per essere sottoposti all’azione digestiva del succo gastrico.