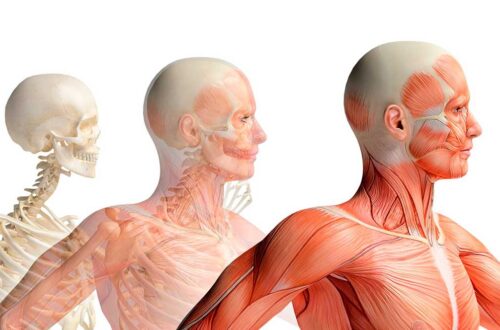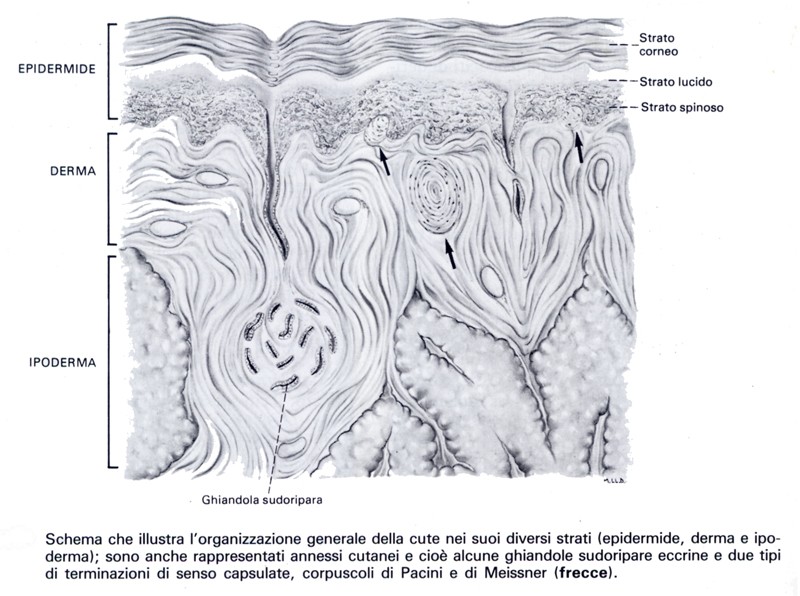Plesso lombare
I rami anteriori del 1°, 2°, 3° e di parte del 4° nervo lombare formano il plesso lombare. Concorre alla costituzione di questo plesso anche un ramo anastomotico che discende dall’ultimo nervo intercostale. I rami anteriori dei primi 3 nervi lombari emettono un ramo anastomotico che, con direzione quasi verticale, scende al ramo anteriore del nervo sottostante. Inoltre, il ramo anteriore del 1° nervo lombare riceve l’anastomosi dal ramo anteriore del 12° nervo toracico e il ramo del 4° nervo lombare dà una grossa anastomosi che scende al ramo anteriore del 5° nervo lombare, per formare con esso il tronco lombosacrale. Ogni ramo anteriore, o radice del plesso, si divide…
Apparato genitale femminile
L’apparato genitale femminile è costituito da un insieme di organi che hanno il compito di produrre le cellule germinali femminili (o cellule uovo od ovociti), di permetterne l’incontro con le cellule germinali maschili (o spermatozoi) ai fini della fecondazione, di accogliere il prodotto del concepimento durante la gravidanza e di espellerlo all’esterno, al termine di essa. A livello dell’apparato genitale femminile, inoltre, si svolgono importanti funzioni endocrine che stabiliscono le condizioni idonee affinché le varie parti possano adempiere ai loro compiti.
Lesioni encefaliche
Le lesioni encefaliche traumatiche rientrano tra le lesioni contusive; possono essere suddivise in due gruppi: lesioni da impatto diretto e lesioni da decelerazione o accelerazione; queste ultime, dovute alla succussione della massa encefalica, sono associate alla trazione delle strutture vascolo-nervose a ponte con la possibile comparsa contemporanea di piccole ecchimosi corticali, di emorragie leptomeningee e/o di un danno assonale diffuso. È possibile distinguere sei tipi differenti di lesioni contusive a livello encefalico: Contusioni da impatto diretto: piccole ecchimosi corticali (cortical contusions), spesso multiple, che si realizzano per meccanismo diretto nella sede del trauma per impatto fra la massa encefalica e la diploe interna della teca cranica che può comunque essere…
Muscolo retto laterale dell’occhio (o bulbo oculare)
Il muscolo retto laterale dell’occhio (o bulbo oculare) è innervato dal nervo abducente (VI paio dei nervi encefalici); contraendosi, ruota il bulbo oculare sul piano orizzontale, spostandone il polo anteriore in senso laterale. Origina dal segmento laterale dell’anello tendineo comune (di Zinn) e, con un capo accessorio, dal margine inferiore della fessura orbitaria superiore. Decorre in vicinanza della parete laterale dell’orbita e s’inserisce sulla superficie laterale della sclera, a circa 7 mm di distanza dal limbus. Articolo creato l’1 ottobre 2012. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Recettori dell’acido retinoico e dell’acido 9-cis-retinoico
I recettori dell’acido retinico (RAR) e dell’acido 9-cis-retinoico (RXR) appartengono, rispettivamente, alla I e alla II classe dei recettori intracellulari.La caratteristica del recettore dell’acido 9-cis-retinoico è che quando viene attivato non dimerizza con i recettori della stessa classe ma con altri recettori orfani o appartenenti alla prima classe. Articolo creato il 20 ottobre 2010. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Struttura del corpo vitreo
La struttura del corpo vitreo, di difficile indagine microscopica, appare realizzata da una trama reticolare di fibrille simili alle collagene, molto fini, di spessore tra i 6 e i 15 nm con un periodo di 64 nm; nelle maglie della trama è contenuto un gel ricco di acido ialuronico. Il corpo vitreo contiene inoltre alcune cellule, gli ialociti, dislocate specialmente nella sua parte periferica, che probabilmente sono leucociti modificati nella loro struttura. Articolo creato il 16 settembre 2012. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Prova ufficiale concorso SSM 2024
In questa pagina è possibile effettuare la prova ufficiale del concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione Mediche 2024 (SSM 2024) secondo le regole ufficiali, ovvero: 140 domande a risposta multipla, ognuna con 5 possibili risposte; 1 sola risposta corretta; 1 punto per risposta corretta; 0 punti per risposta non data; -0,25 punti per risposta sbagliata; 210 minuti di tempo. Le risposte corrette/errate saranno visualizzate al termine della prova. Il risultato sarà visualizzato entro 30 secondi, quindi attendere dopo aver cliccato su “Risultato”. Se la prova non è completata nel tempo stabilito, il quiz sarà automaticamente terminato e visualizzato il punteggio. Tutte le domande/risposte sono quelle ufficiali SSM 2024. Ogni…
Impiccamento
L’impiccamento rappresenta una forma di asfissia provocata dalla compressione del collo da un laccio fissato ad una estremità e stirato verso il basso dal peso del corpo, completamente o incompletamente sospeso. Un laccio (corda, cinghia, lenzuolo, asciugamani) viene in genere fissato con un estremo ad un punto elevato, l'altra estremità viene annodata ad ansa fissa o mediante nodo scorsoio. L'individuo si pone in una posizione più alta rispetto al suolo (ad esempio, salendo su una scala), fa passare il capo dentro l'ansa (ponendo quindi il cappio intorno al collo), e si abbandona nel vuoto.
Peptide inibitore gastrico
Il peptide inibitore gastrico (GIP) aumenta nel suo tasso ematico a seguito di un pasto lipidico o glucidico. È un polipeptide di 43 aminoacidi prodotto dalle cellule K che si trovano in massima concentrazione nella mucosa digiunale e, in minor numero, nella mucosa duodenale. I granuli delle cellule K sono di forma tondeggiante, grandi (350 nm) e presentano un nucleo osmiofilo, argirofobo, immerso in una matrice densa fortemente argirofila. Gli effetti del GIP sono molteplici: inibisce la motilità e l’attività secretiva gastrica, stimola la secrezione intestinale e stimola inoltre la secrezione di insulina e di glucagone da parte delle cellule endocrine del pancreas. Articolo creato il 15 agosto 2011. Ultimo…
Articolazioni della laringe
Le cartilagini laringee principali sono fra loro connesse tramite le articolazioni laringee, o per mezzo di legamenti a distanza detti legamenti intrinseci. Sono inoltre unite agli organi vicini per mezzo di legamenti estrinseci. Le articolazioni della laringe sono le cricotiroidee, le cricoaritenoidee e le aricorniculate.