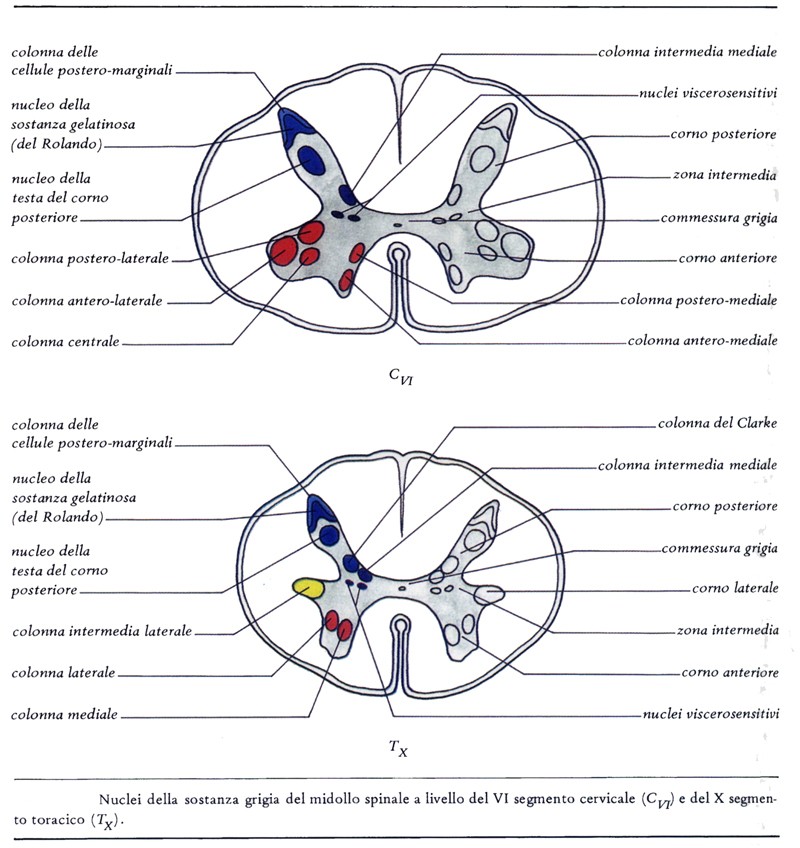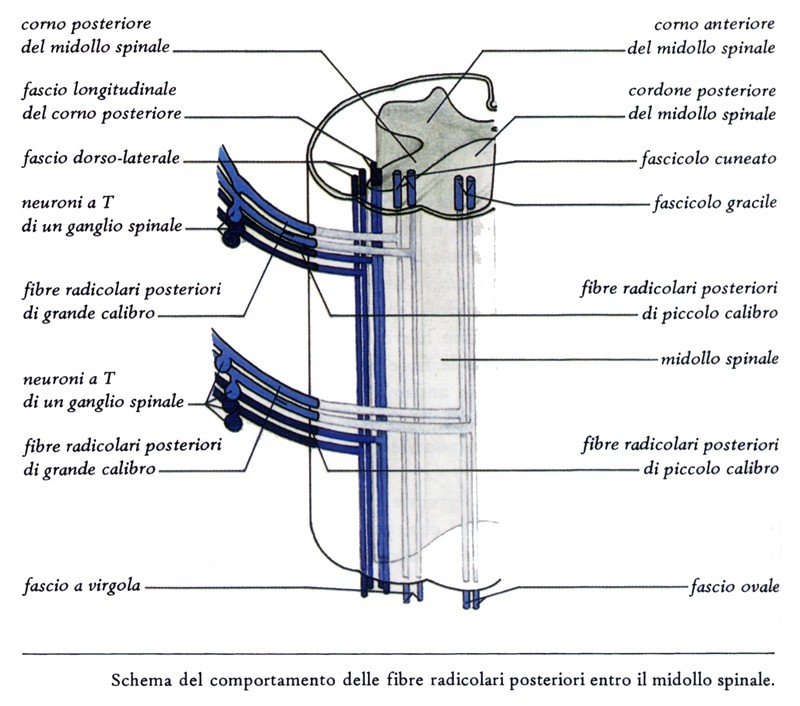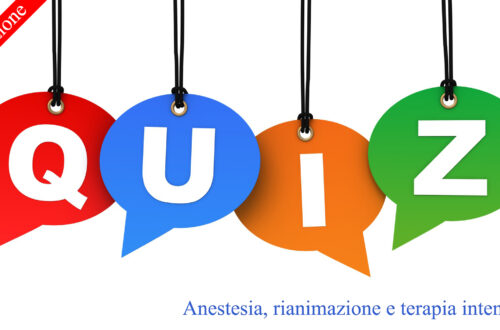Osteociti
Gli osteociti sono le cellule più numerose nell’osso che ha completato il suo sviluppo. Sono essenzialmente osteoblasti che, dopo aver elaborato la sostanza ossea, rimangono imprigionati nella matrice calcificata nell’interno di lacune ossee, cavità a forma lenticolare scavate nelle lamelle. Gli osteociti hanno la forma delle lacune ossee in cui sono accolti. Il corpo cellulare è appiattito, dovendosi adattare alla forma lenticolare della cavità che lo contiene ed è provvisto di numerosi e sottili prolungamenti alloggiati nei canalicoli ossei.
Fisiologia renale
La fisiologia renale si occupa dello studio delle funzioni del rene e dei processi che coinvolgono l’apparato urinario. Articolo creato l’8 agosto 2011. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Trattamenti sanitari volontari
L’informazione da parte del medico ed il consenso alle cure da parte del paziente, che rappresentano gli elementi fondanti dei trattamenti sanitari volontari, devono essere considerati come un binomio inscindibile poiché se è vero che l’informazione al paziente deve essere data anche senza finalità di acquisizione del consenso, come ricorda l’articolo 35 del codice di Deontologia Medica, il consenso non può essere ritenuto valido se non è preceduto da idonea informazione sugli accertamenti ed i trattamenti sanitari che vengono proposti al cittadino/paziente. Aspetti etici Il consenso informato è nato per soddisfare il principio di autonomia, simbolo di una moderna responsabilizzazione dei soggetti nei riguardi della propria salute e di una…
Examen oficial MIR 2018
In questa pagina è possibile effettuare una prova ufficiale del concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione Mediche 2018 in Spagna (MIR 2018) secondo le regole ufficiali, ovvero: 225 domande (+ 10 di riserva) a risposta multipla, ognuna con 4 possibili risposte; 1 sola risposta corretta; 3 punti per risposta corretta; 0 punti per risposta non data; -1 punto per risposta errata; 300 minuti di tempo. Le risposte corrette/errate saranno visualizzate al termine della prova. Il risultato sarà visualizzato entro 30 secondi, quindi attendere dopo aver cliccato su “Risultato”. Se la prova non è completata nel tempo stabilito, il quiz sarà automaticamente terminato e visualizzato il punteggio. Ogni volta che…
Sterilizzazione volontaria
Per sterilizzazione umana s’intende il ricorso ad interventi finalizzati ad assicurare la soppressione, sia nell'uomo che nella donna, della capacità di procreare. Detta finalità è perseguita mediante interventi che vanno dalla semplice legatura, rispettivamente dei dotti deferenti nell'uomo e delle tube della donna, alla loro resezione. Di solito consegue una sterilizzazione permanente atteso che il ripristino, in epoca successiva, della capacità di procreare non è propriamente agevole, spesso è bisognevole di interventi di ricanalizzazione microchirurgica, non sempre idonei a ripristinare una condizione di fertilità.
Accanimento terapeutico (o distanasia)
Per accanimento terapeutico (o distanasia) s’intende la prosecuzione ostinata e senza scopo di un trattamento che risulti inutile per il paziente, ovvero la persistenza nell'uso di procedure diagnostiche come pure di interventi terapeutici, allorché è comprovata la loro inefficacia e inutilità sul piano di un'evoluzione positiva e di un miglioramento del paziente, sia in termini clinici che in qualità di vita.
Quiz di scienza dell’alimentazione
In questa pagina è possibile esercitarsi su quiz di scienza dell’alimentazione. Puoi scegliere un test da 10, 25, 50, 100 o 140 domande, estratte da un archivio di centinaia di domande (della stessa disciplina). Ogni volta che si ripete un quiz le domande saranno diverse e l’ordine delle risposte mescolato. Ogni domanda presenta 5 possibili risposte di cui 1 sola corretta. Le risposte corrette/errate saranno visualizzate subito dopo aver risposto, nonché al termine del quiz. Per esercitarti su altre discipline o simulazioni, vai qui. Hai riscontrato errori? Invia un messaggio per comunicarlo! Attenzione! Tutti i quiz possono essere svolti liberamente, senza registrazione al sito. Se si desidera archiviare le prove effettuate nella…
Canali del potassio di tipo A (o a corrente transiente)
I canali del potassio di tipo A (o a corrente transiente) (KA) sono canali a 6 α-eliche transmembrana (6 STM) che si aprono in modo transiente quando una cellula si depolarizza in seguito ad un’iperpolarizzazione. La loro funzione è quella di stabilizzare il potenziale di riposo delle cellule nervose e ridurre la frequenza dei treni di potenziali d’azione. Articolo creato il 3 ottobre 2010. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.
Arteria uterina
L’arteria uterina è un ramo viscerale del tronco anteriore dell’arteria iliaca interna. È omologa, nella femmina, dell'arteria vescicolodeferenziale del maschio.
Scapola
La scapola è un osso pari, piatto, sottile, di forma triangolare, con la base superiore e l’apice inferiore che, insieme alla clavicola, rientra nella costituzione della cintura toracica (o cingolo toracico), ossia il dispositivo che unisce la parte libera dell’arto superiore al torace. La scapola si applica alla parte postero-superiore del torace, a un livello compreso tra la 3a e la 7a costa. Vi si descrivono una faccia anteriore (o costale), una faccia posteriore (o dorsale), tre margini di cui uno mediale (o vertebrale), uno laterale (o ascellare) ed uno superiore, e tre angoli che si distinguono in laterale, mediale e inferiore. La faccia anteriore (o costale) presenta una leggera…